
IL CABARET
Vorrei dire qualche cosa su un mondo che è sparito e che ha rappresentato una delle punte massime della cultura italiana: Il Cabaret.
Nei
nostri Cabaret scherzavamo sulle cose
che ci sembravano palesemente oscure, osavamo deridere chi non se la
sentiva di
rischiare e contrapporci umoristicamente a un modo di esistere
arrendevolmente borghese. Ed era persino divertente fare le pulci al
potere, in un
periodo in cui tutta la politica appariva rigida, quasi ingessata e i
media
stavano appena imparando ad avere solo se stessi come riferimento.
Resta solo da chiederci come lo abbiamo
speso, quel tempo che è stato vissuto su quei palcoscenici; ma mentre
ce lo chiediamo, sappiamo già che ormai non possiamo fare di più: il
tempo
passato non ritorna. Però possiamo, almeno, non suffragare menzogne. In
questo
scritto ci sono parecchi riferimenti a Luciano Cirri, personaggio
unico di
quel periodo storico che, purtroppo, ci ha lasciato troppo presto,
insieme a
una serie di interrogativi, di domande e di quesiti mai risolti.
A
lui
soprattutto devo molto della mia
attività artistica. Per i consigli ricevuti, per la fiducia che lui mi
ha
accordato, per quella forma di amore – odio che egli nutriva per tutte
le
persone a cui egli voleva sinceramente bene e di cui, in qualche modo,
fui
oggetto anche io.
Ma
partiamo dagli inizi. Il
collegamento
naturale di questo genere è con la Commedia Attica nuova, le commedie
Osche
(Atellane), Plauto, la Commedia dell’Arte; ma le sue autentiche origini
moderne
si possono collocare in quelle taverne parigine o cambrettes (da cui il
termine
cabaret) che artisti e letterati come Villon, Gringoire e Rabelet erano
soliti
frequentare. Da luogo di incontro per scambi di idee e di esperienze, o
per la
lettura di versi o brani inediti, il cabaret assunse in breve tempo la
caratteristica di ritrovo - spettacolo per le esibizioni di artisti
che, con il
loro modo di proporsi caratterizzato da una particolare vena di
anticonformismo
e di spregiudicatezza, ne fece la pedana ideale dei movimenti artistici
e
d’avanguardia del periodo a cavallo tra l’ottocento e il novecento. Il primo di questi locali fu fondato
nel 1881 a
Parigi nel
quartiere di Montmartre e si chiamava Le
cabaret artistique de Rodolphe Salis, subito dopo rinominato Le Chat Noir. Altri cabaret del periodo
furono il Cabaret des Quat'z'Arts, La
Lune rousse e
Les
Pantins. Dalla Francia, il Cabaret si trapiantò
ben presto
in
Germania dove, per la particolare congenialità dello spirito tedesco,
mise
profonde radici. E fu lì che si affermò
quella predilezione per la satira sociale, politica e di
costume
che ha costituito
la tematica dominante anche dei nostri Cabaret. Il film Cabaret, con
Liza
Minnelli, ricorda in maniera abbastanza felice quel periodo.
Fu
proprio nel 1900 che venne affrontato
da Ernst von Wolzogen il primo esperimento di cabaret tedesco, che al
tempo era
chiamato Buntes Theater (teatro
colorato), ma il genere Kabarett
prese
veramente piede tra gli anni venti e gli anni trenta del Novecento
portando al
successo artisti come Karl Valentin al Wien-München
e Werner Finck al Kathakombe. Una
delle tecniche più
applaudite di questo eccezionale personaggio era il fingere di non
riuscire a
trovare le parole per concludere un discorso, in modo che il pubblico
potesse
comprendere da solo la battuta non completamente pronunciata. Questo
ovviamente
scatenava la risata.

Il
10 maggio 1935 il ministro
della Propaganda nazista Joseph Goebbels fece
chiudere il Kathakombe. Finck venne
arrestato e condannato ma la sua pena venne commutata in un periodo di
interdizione ai locali pubblici. Tuttavia, nel 1937
tornò di nuovo ad esibirsi e lo fece al Kabarett
der Komiker.
Anche questo locale venne
chiuso dal regime nel 1939.
Sembra quasi assurdo ma, per sfuggire ad un ulteriore arresto, Finck si
arruolò "volontario" per
il fronte: gli venne assegnato l'incarico di radiotelegrafista e
combatté in Francia, Unione Sovietica e Italia dove nel 1945 venne
fatto prigioniero dagli Alleati che
non volevano credere che egli fosse il famoso fustigatore dei vizi dei
gerarchi
nazisti. Dopo la seconda guerra mondiale Werner Finck si esibì ancora
nel
cabaret Nebelhorn di Zurigo e in seguito al Mausefalle
di
Stoccarda.
In
Italia,
la comicità fatta di critica e satira social - politica
iniziò negli ambienti di varietà con Petrolini, De Angelis, Maldacea e
altri. Nel
dopoguerra una
delle prime formazioni moderne fu quella dei Gobbi
con
Bonucci, Caprioli e Franca Valeri. Presentavano testi creati
da loro e che essi stessi rappresentavano, rigidamente, come erano
stati
scritti. La caratteristica del testo teatrale fu poi ripresa dagli
autori del Bagaglino, che
intendevano fare proprio
un Teatro - Cabaret, e diffusa in tutto il centro sud. Si trattava
pertanto di Cabaret
d'autore, dove l'attore poteva inserire qualcosa di suo ma non
inventare di
sana pianta lo spettacolo. Viceversa il Cabaret d'attore prevede
personaggi
che, sfruttando le loro capacità istrioniche, conversano con il
pubblico
variando il testo della rappresentazione, che il più delle volte
scrivono da
soli. A
Milano il cabaret prese vita, nel
1963 al Derby club, grazie al
ristoratore Bongiovanni e al jazzista Intra, cui si affiancò subito
Franco
Nebbia straordinario musicista intrattenitore che eseguiva canzoncine
dal
sapore goliardico. Fu con Intra e Nebbia che nacque il primo manipolo
di
talenti. Di solito si trattava di artisti che si esibivano da soli. Con
i Gufi,
prima, e i Gatti di Vicolo Miracoli, dopo, sopravvenne un notevole
cambiamento
verso formazioni di gruppo. Nel 1970 - 71, nel centro storico della
città, si
aprì il Refettorio, gestito da
Roberto Brivio, uno dei Gufi, che cercò di contrapporsi con scarso
successo
all'ormai lanciatissimo locale di viale Monte Rosa. Sempre a Milano una
ribalta
piuttosto affermata del Cabaret fu lo Zelig
che riuscì a rivelare diversi comici, avviandone o accelerandone il
successo. E
va menzionato anche il Ciak di
Milano, un cinema di periferia che si trasformò nel 1977 in teatro di
Cabaret. Dopo
Milano, fu la volta di Roma. Nel 1965 Maurizio Costanzo aprì nella
capitale, in
via della Vite, il Cab 37 scoprendo
e
lanciando Paolo Villaggio, Gianfranco D'Angelo, Pippo Franco e il
cantastorie
Silvano Spadaccino. Costanzo con il suo gruppo si trasferì poi al Setteperotto, in via dei Panieri 56. E
qui fece debuttare un giovanotto alto e magro che recitava e cantava
accompagnandosi alla chitarra: era Proietti Luigi detto Gigi. Sempre a
Roma e sempre nel 1965, esplose Il
Bagaglino, guidato da un gruppo di giornalisti: Mario
Castellacci,
Piero
Palumbo, Pierfrancesco Pingitore
e
Luciano Cirri ai
quali si aggregarono Gianfranco Finaldi e il musicista Dimitri
Gribanovski.
Questo Teatro Cabaret fu una vera fucina di idee fuori
da ogni tendenza, una autentica novità, per il periodo. Causò un vero
terremoto, nel mondo dello spettacolo.

In
tutti quegli anni, furono
due le
grandi
tendenze che caratterizzarono questo tipo di rappresentazione: quella
del Cabaret
d'attore e quella del Cabaret d'autore. Nel Cabaret d’attore,
l’interprete può
anche improvvisare. Nel cabaret d’autore è molto più difficile perché
l’attore
ha un copione da seguire e le digressioni possibili non sono molte.
Inoltre, a
distinguere i due tipi di Cabaret, intervenne
soprattutto lo stile. Quello milanese era meno impegnato e sicuramente
alla
portata di tutti. Quello romano, ricco di sfumature, di riferimenti e
di giochi
di parole, era più raffinato e dedicato a un pubblico certamente più
colto ed
informato anche delle vicende della politica, di cui Roma era il
centro. Ma cerchiamo di capire meglio qual è la struttura del Cabaret.
Come tutti
sanno, si tratta di un genere di spettacolo molto particolare. Non c’è
o è
ridotto al minimo lo scenario, non è una vera e propria
rappresentazione e questo
non consente un autentico appoggio sui personaggi che variano
continuamente.
Non esiste una trama vera e propria, ma soltanto un pretesto: un esile
filo
conduttore per seguire il quale l’artista si deve destreggiare come un
funambolo. Inoltre, avendo una forte presa emotiva sul pubblico, crea
una
enorme tensione per lo stesso artista che, senza poter disporre di
effetti
particolari, deve mantenere una sorta di rapporto magico e di intensa
partecipazione con gli spettatori. Sia che affronti aspetti comici, sia
che si
appoggi alla poesia. è
logico
perciò che questo sia diventato naturalmente un genere di spettacolo da godere
preferibilmente in
ambienti piccoli, dove gli effetti sonori e luminosi, che sono comunque
sempre
ridotti al minimo, possono raggiungere quella particolarissima
suggestione che
viene creata dall’immediata vicinanza tra artista e pubblico che,
spesso
coinvolto, può diventare egli stesso protagonista della
rappresentazione. Credo
di poter affermare senza paura di essere smentito che, per questo
motivo, la
televisione sminuisca il Cabaret proprio perché questo genere di
spettacolo ha
bisogno della partecipazione diretta del pubblico. I vari tentativi che
sono
stati fatti non possono essere considerati vero cabaret, ma si
avvicinano di
più all’altro citato tipo di spettacolo, sempre di origine francese: il
cafè
chantant! Infatti mentre il cabaret
rimane comunque uno spettacolo di rottura, di protesta, nel cafè
chantant la
protesta non c’è più: c’è rassegnazione e quasi compiacimento. Ecco
perché
risulta più adatto alla televisione. Del resto il mezzo televisivo
essendo un
media di massa, non consente molta concentrazione, è dispersivo e
soprattutto tende
verso altri fini. Invece il Cabaret, che in fondo deriva da espressioni
di
popolo, al popolo intende ritornare come divertente mezzo per far
riflettere e,
se è vero che questo genere è stato creato da intellettuali, è pur vero
che a
usufruirne è stata la parte più sensibile del popolo, che ricerca e
ritrova la
rabbia, la malinconia e anche l’umorismo di antiche espressioni e canti
nati
tra la gente comune per motivi di protesta o di gioia. Non importa
quale sia la
tendenza del Cabaret, i meccanismi sono sempre gli stessi.
A
questo
punto è
necessario dire qualche cosa di più su questo controverso personaggio.
Era nato
a Pisa il 18 agosto 1931 da una buona famiglia, piuttosto colta ma di
modeste
possibilità economiche, che tuttavia aveva voluto per il loro figliolo
l’accesso a una buona istruzione. Il giovane Luciano aveva messo bene a
frutto
quelle possibilità e in brevissimo tempo era diventato uno dei giovani
intellettuali di quella destra rivoluzionaria, che si riconduceva
all’aspro
spirito di una certa toscanità. Luciano aveva conosciuto Giovanna,
quella che
sarebbe diventata sua moglie, sui banchi di scuola. Insieme avevano
combattuto
quelle battaglie studentesche che vedevano scontrarsi continuamente
gruppi di
destra e di sinistra. Insomma i due crebbero praticamente insieme nelle
fila
dei giovani di destra. Poi arrivò il giorno in cui Giovanna si fidanzò
e decise
di sposarsi con un amico di Luciano, ma egli la dissuase dicendole: “Non puoi sposare lui, devi sposare me.” -
e alle proteste di lei aggiungeva – “Gli
faresti solo del male perché, se tu lo sposassi, io e te finiremmo con
il
diventare amanti. Pertanto è meglio che il rischio lo corra io. Credimi
è per
puro spirito di altruismo che lo faccio!” - Tanto senso
dell’umorismo e
tanta sfacciataggine non potevano non sortire l’effetto da lui
desiderato. Questo
fatto mi fu raccontato dallo stesso Cirri. E così accadde che, lasciato
il fidanzato
in una crisi di nervi (secondo me procuratale dallo stesso luciano),
dopo un
ragionevole lasso di
tempo, Giovanna si fece condurre all’altare dal suo affascinate e
impudente
camerata. Le foto
ci dicono che erano
veramente una bella coppia e io so che lo erano ancora quando li
conobbi. La
cosa strana è che io non incontrai Giovanna come moglie di Luciano,
bensì come
energica dirigente proprio della casa discografica RCA con la quale
avevo
cominciato a avere frequenti contatti. Ma in quel periodo ignoravo
completamente che fosse la moglie di Luciano Cirri. Era una di quelle
donne che
vengono definite di carattere,
tutto
pepe e decisione. Una di quelle persone che ti fanno sentire il bisogno
di
correre anche quando la tua pigrizia ti frena. Avevano una figlia che
adoravano: Francesca. A lei Luciano aveva dedicato una delle sue più
struggenti
canzoni Ninna nanna a Francesca, in
cui egli aveva nascosto molti dei suoi sentimenti e delle sue
frustrazioni.
Inutile continuare a raccontare come egli fosse continuamente
circondato da
donne bellissime e desiderose di avere almeno un invito a cena, da
parte sua.
E
Cirri
riusciva a
destreggiarsi con una abilità unica. Ma questa è una cosa che riguarda
solo un
aspetto della sua vita e che non fa parte della nostra storia.
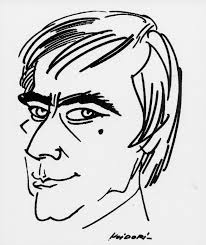
Un
giorno, dissi, sarà come se
il mio nome e il mio viso fossero impressi sul cielo, coi colori
dell'arcobaleno. La gente d’ogni paese e d'ogni città, di qualsiasi
meridiano,
se è vero che nulla come il cielo e uguale per tutti, alzando gli occhi
vedrà
questo viso e questo nome e saprà che ho scritto, creato, sofferto,
bestemmiato, pregato, sbagliato per lei. E se è vero che il cielo è
immutabile,
non morirò mai, e sarò più vivo di oggi per tutti.
sono
le mie sconfitte,
ma
nessuno le acquista,
nemmeno
a rate
queste
mie ore disperate.
Bambine
mie ve lo giuro
nelle
vostre piccole mani,
c'è
tutto il mio niente,
il
mio inesistente domani.
Negli
occhi d'un gatto
c’è
tutto: detto e non fatto.
L.V.-
Cara Francesca, questi pensieri sono gli ultimi che tuo
padre ha scritto nei giorni precedenti la sua morte. Come sempre
riusciva a
sintetizzare in poche righe un universo di sentimenti. Cosa ricordi di
quel
periodo?
Fran-
Tutto. Ricordo ogni singolo momento, ogni parola detta, ogni
palpito di vento, ogni sfumatura di colore, ogni silenzio. È evidente
che egli
intuiva che la fiamma della vita si stava spegnendo in lui, ma mai un
cedimento
con noi, mai un attimo di tristezza o paura, solo questi pensieri
ritrovati a
giorni dalla sua morte da mia madre nello studio di casa su un taccuino
di
pelle. Aveva vissuto l'ultimo inverno a casa circondato dall'amore e
dalla
dedizione di mia madre e mia, in compagnia, si fa per dire, di due
gatte, che
lo studiavano a distanza, e lui loro, con le quali evidentemente
comunicava con
gli sguardi. caro amato padre, fossi stata anch'io una gatta mi sarei
accorta
delle tue ore disperate.
L.V.-
Cosa conservi?
Fran-
I valori che mi ha trasmesso, la qualità di vita che mi ha
insegnato,
mi hanno portato sempre a
scegliere il giusto.
Essere fedeli a se stessi, ai propri ideali, ai propri sogni
migliori, prendere con ironia e un poco di cinismo i fatti che ci
circondano,
essere persone serie senza però prendersi troppo sul serio, affrontare
la vita
a viso alto e non rammaricarsi troppo per gli sbagli.
L.V.-
Parlavate molto, tra voi?
Fran-
All’inizio, quando ero troppo piccola e prima che si
instaurasse la tradizione dei bigliettini che ci scrivevamo quasi
quotidianamente. Durante i lunghi, meravigliosi anni che ho potuto
stargli
accanto, ci siamo sempre scritti dei biglietti per comunicare il nostro
affetto. Ricordo
che
io li lasciavo sul
suo comodino o sulla scrivania, affinché lui li ritrovasse, rincasando.
L.V.-
E lui come ti rispondeva?
Fran-
Con altri bigliettini che io trovavo sul mio lettino,
puntualmente, la mattina seguente. Non si trattava di lunghe lettere, o
perlomeno non sempre. Il più delle volte erano semplici frasi in cui io
raccontavo quello che ritenevo fosse importante tra le cose che avevo
fatto
durante la giornata, qualche impressione, la richiesta di un consiglio,
un
semplice "ti voglio bene, papà". Quasi avessimo paura di
comunicarci direttamente i nostri sentimenti, ma in realtà perché
avevamo
limitate occasioni per incontrarci, lo scrivere tra noi è stato sempre
un
elemento fondamentale del nostro rapporto. Se doveva dirmi cose troppo
importanti e che non avrei compreso, ne faceva un articolo e lo
pubblicava sui
giornali. I fatti di famiglia diventavano così argomento di articoli e,
le
nostre storie, dominio pubblico. Come nel caso della morte di mia nonna
Lina.
Anche questo può essere utile per comprendere chi fosse realmente
Luciano Cirri
e quanta poesia e sensibilità ci fossero in lui. Per tutti, egli è
stato il
giornalista, l’autore, lo scrittore, il poeta. Per me era soprattutto
il Padre.
Lo dico con la P maiuscola perché egli la meritava. Ma per non
incorrere in
quelli che qualcuno potrebbe definire sentimentalismi postumi,
preferisco far
raccontare Luciano Cirri da lui stesso, attraverso alcuni scritti
inediti che
egli ci ha lasciato.
Voglio
confessare subito che quando ho letto sui giornali e
sentito dalla Rai la proposta di "adottare un anziano", sono restato
alquanto perplesso. Anch'io sono presumibilmente anziano, e nessuno mi
adotta.
Anzi, da molti anni sono costretto a fare da tutore ad una figlia, una
moglie,
una signorina che aiuta nelle faccende di casa, una robusta signora che
sbriga,
ad ore, i lavori più pesanti, e due gatte. Ogni tanto mi viene la
voglia di parlare,
finalmente, con un uomo. L'altra sera mi sono imbattuto in un signore
che
sembrava più antico che vecchio, con una lunga barba bianca e uno
scintillante
sguardo azzurro. Gli ho detto, vedendolo vacillare sotto il peso di una
secolare stanchezza: "Mi scusi, posso aiutarla?". Mi ha guardato per
un interminabile momento. Poi ha detto: "Si, se puoi darmi qualche
milione
in contanti oppure se puoi portarmi a casa tua!". Non avevo milioni in
contanti, e l'ho portato in casa mia. Non e una reggia, ovviamente. Ma
si
troverà sempre il modo di arrangiarsi. Così, ho "catturato"
quest'uomo davvero importante, distrutto da diverse vicissitudini
esistenziali
che non voglio riferire. Gli ho chiesto soltanto di preparare e disfare
da solo
il divano-letto nel mio studio. Ed egli lo fa con grande precisione.
Ora siamo
diventati grandi amici, e spero che non se ne vada mai. Ha settantasei
anni. E'
bravo, colto, gentile, educatissimo. Mia figlia lo adora come un nonno
ritrovato, mia moglie lo guarda adorante rimpiangendo i sessanta anni
che
dividono i loro destini, le gatte tentano di mostrargli il loro affetto
mordendogli con dolcezza le grandi mani venate d'azzurro. Non racconto
la sua
storia, perché non mi perdonerebbe. Fatto è che, da vecchio, si è
trovato solo
e disperato. Sino a questo momento gli piace la mia famiglia. E la mia
famiglia
si è innamorata di lui. Ma, involontariamente, ci ha creato un grave
problema:
tutti noi viviamo nel terrore di dire o fare qualche cosa che possa
dargli
dispiacere e lo induca a lasciarci soli, senza il bene del suo grande
sorriso
sdentato. Rientriamo tutti più presto del solito a casa, a parte i
gatti che vi
restano sempre, perché abbiamo voglia di sentire la sua voce, le sue
favole, le
sue speranze. Dice, ad esempio: "Quando diventerò ricco...". Non
diventerà mai ricco, ma ci crede ancora. La differenza tra lui e me è
proprio
in questo: io so bene che non diventerò mai ricco, e, pensandoci bene,
non
m'interesserebbe molto diventarlo. Ma lui vorrebbe, per regalare culle
dorate
alle mie gatte, abiti fastosi a mia moglie, pigiami di favola a mia
figlia.
Basta,
però, con questo resoconto autentico dl un fatto
"strappalacrime". Avrei voluto dire soltanto che i vecchi, come
saremo tutti noi un giorno o l'altro, sono spesso anime favolose e
splendide.
Il solo errore è che non bisogna "adottare un nonno"; siamo noi che
dobbiamo farci adottare da lui.
L.V.-
Ma è tutto vero? Avete veramente adottato un vecchietto?
Fran-
Le cose sono andate proprio come le ha esposte. La sua
generosità faceva parte della sua natura. Anche per questo non aveva
mai un
soldo in tasca: se c’era qualcuno che gli chiedeva aiuto, non era
capace di
rifiutarglielo. Anche se aveva un formidabile "gusto del NO", non
poteva dirlo a chi aveva bisogno di un suo aiuto.
L.V.
- Cosa mi dici di tuo padre "scrittore"?
Fran-
L'amore di mio padre per la scrittura risale all'infanzia, e
nell'adolescenza, durante il
liceo
scriveva per ''la rivolta ideale'', giornale politico culturale, nel
periodo
universitario per ''30 e lode ", i suoi sono stati spesso racconti
presi
dalla vita per raccontare e raccontarsi, a volte immaginari. ma la
poesia e la
tenerezza nel descriverli era la stessa. i ricordi della sua
adolescenza di
giovane di destra, di ragazzo povero ma ricco di ideali, speranze e
forza.
L.V.-
Parlami delle vacanze che facevate insieme.
Fran-
Quelle che ricordo con maggiore tenerezza, sono le vacanze
passate tra le montagne, dove ancora oggi i vecchi amici rimasti sono
in
contatto con mia madre e lo ricordano con rimpianto, tra i montanari,
in quel
minuscolo paesino sul Piave chiamato campolongo, '' ...oasi
miracolosamente
scampata al progresso.. ". Dove anche io ho mosso i primi passi,
portata
fin dai due mesi da mia madre e mio padre. Quante passeggiate mano
nella mano e
poi, di sera, tutti davanti al camino con i canti montanari e un buon
bicchiere
di grappa.
La
maggior parte degli italiani ricomincia il lavoro. Soltanto i
più raffinati conoscono la gioia di andare in villeggiatura a
settembre, quando
le località più belle non sono più gremite di vocianti eserciti di
scamiciati
che cercano di convincersi, urlando, di divertirsi un mondo. Per gli
altri, le
vacanze stanno per finire. Anche per me. Ho cominciato, oggi, a
salutare gli
amici di Campolongo di Cadore, dove ho trascorso questo mese. E' vero
che. ogni
giorno che passa, è l'anniversario del giorno corrispondente l'anno
prima. Ma
occorre un fatto in qualche modo importante, sia r pure un ritorno in
città,
per indurre a fare un consuntivo di una stagione finita, e dei giorni
trascorsi
dall’identica partenza, l'anno passato : Che cosa è accaduto
in
quest’anno ? Vita di sempre, solita vita, a considerarla così,
un
blocco
di mesi e di giornate fissate ormai in un totale. Ma le ore, se
riuscite a
ricordarle, sono state intense e difficili, serene o angosciate, e si
era più
giovani di un anno, di quando siamo andati via l'altra volta, e tutto
si è
svolto così in fretta che ci siamo trovati nuovamente in vacanza, e
nuovamente
sul punto di partire, senza che un nume ci avvertisse che è questo il
modo
sornione e perfido con cui il destino ci ruba, rosicchiandola piano e
senza far
male, la vita. Ed è triste finire la vacanza, quando non si riesce a
pensare
più, com'era facile pensare una volta, che i mesi di lavoro che ci
attendono ci
porteranno tutta la gloria, tutta la fortuna e tutte le vittorie in cui
una
volta sapevamo credere.
L.V.-
Era un tradizionalista?
Fran-
Per lui, tutto ciò che era "tradizione" appariva
estremamente importante. Diceva che le tradizioni sono le radici dei
popoli, ma
anche delle singole persone. Questo "voler conservare le cose buone"
era, per lui, non solo un riferimento culturale, ma una certezza della
sua
esistenza.
L.V.-
Eppure non sembrava un casalingo.
Fran-
No, non lo era. Ma quando mio padre parlava della casa,
della sua casa, parlava di un sogno. Forse è proprio questo il motivo
per cui
cambiare casa, per mio padre, equivaleva al verificarsi di una
tragedia. Perché
nella casa che lasciava, talvolta per una più bella ma "troppo"
nuova, erano legati i sogni, i ricordi, le speranze di una parte della
sua
vita.
Mi
trovo a passare nella strada dove ho vissuto tanti anni della
mia vita, i più duri, i più dolci, i più saggi, i più folli. Quieta,
nascosta
casetta al secondo piano di viale Gorizia! Durante la guerra, lo
scantinato era
divenuto un rifugio, ma un rifugio alla buona, che serviva soltanto a
far
dimenticare la paura delle bombe resuscitando o provocando dolori
reumatici con
l'umidità che gocciava dai muri come pianto: quattro travi, un
estintore e due
sacchetti di sabbia. Finirono quegli anni, e mi trovai d'improvviso,
quasi
senza accorgermene, non più bambino. Quando mia sorella si sposò, potei
infine
avere una stanza tutta per me: l'arredai con semplicità, come una cella
francescana: una brandina, una scrivania ed un grande scaffale. (Erano
gli anni
in cui era bello pensare alla gloria conquistata con lo studio e con il
lavoro,
studiando, leggendo, scrivendo).
Fu
anche la casa dei primissimi anni di matrimonio. Eravamo molto
poveri, io e Giovanna, ma per quello che posso ricordare, non siamo mai
stati
infelici, in quella casetta gelida. O forse lo siamo stati, a volte, ma
con
rabbia, con entusiasmo, con ribellione, sicuri di noi e di tutto il
bene che ci
toccava e ci sarebbe stato elargito, prima o poi, perché avevamo le
stelle
buone dalla parte nostra. Mai la muta, ottusa infelicità che si
raggiunge più
tardi, quando tutto diventa più sciocco, più inutile e provvisorio, e
d'improvviso ti accorgi che si era grandi soltanto perché si era
giovani, ed è
una grandezza di tutti, non di quella forma particolare che si affina
con la
vecchiaia. Vecchia casa della miseria e dei sogni. No, non una casa
soltanto:
un'isola, un mondo, un mucchio di anni e di sentimenti che, tanto per
farsi
riconoscere, si sono trasformati in pietre, in calce, in mura, in
abitazione.
Una patria, ecco cos'era. E, se penso ad ora, e alla nuova confortevole
casa,
ho la sensazione esatta di quello che può essere una diserzione. Certo,
si vive
meglio, oggi. E avere sposato Giovanna resta l'unico fatto buono e
giusto dei
miei anni sbagliati: non è cambiato molto dentro di noi, per quello che
riguarda noi due. Ma non sappiamo più dirlo con le parole di allora,
quando le
parole erano il nostro caldo e la nostra vita, e non ci vergognavamo dl
confessarci la nostra candida, ingenua e fidente umanità. Tra quelle
mura che
abbiamo perduto e rinnegato, nella illusione di conquistare un’altra
patria per
quello che eravamo, è rimasta aggrappata la nostra buona giovinezza.
L.V.-
Quale era il suo atteggiamento nei confronti di una civiltà
che sembrava avviarsi verso il suo definitivo tramonto?
Fran-
Mio padre si comportava, davanti allo sfacelo della società,
con maggior rigore e con maggiore impegno, quasi a voler dimostrare che
era
possibile comportarsi onestamente e con dignità. Vestiva sempre in
completo ed
era elegantissimo. Era il suo modo di ribellarsi, almeno questo è
quello che
diceva. " In un mondo in cui la maggior parte della gente va in giro
con i
capelli lunghi, sporca, vestita da straccione, l’unico vero
protestatario sono
io che metto sempre giacca e cravatta".
L’altro
giorno, dopo un lungo viaggio di lavoro, tornavo da Milano
in un confortevole treno, evitando un repentino sciopero degli aerei.
Improvvisamente e con mia grande sorpresa, considerata la mia lunga
assenza
dalle Ferrovie di Stato, ho risentito una "voce" che sembrava quella
del buon Dio, pronta a fornire tutte le informazioni ai viaggiatori:
"La
prossima fermata è Bologna"; oppure: "Ci fermeremo a Firenze".
L'annuncio veniva ripetuto in tre o quattro lingue. Ma l'unico
straniero che
viaggiasse a quell'ora e su quella linea, a quanto mi risulta, era un
simpatico
signore seduto di fronte a me, con il quale avevo fatto amicizia.
Parlava un
italo americano molto divertente e abbastanza comprensibile. Ci siamo
recati
insieme al vagone ristorante, e durante il pasto l'ho sentito emettere
suoni
assolutamente inconcepibili per noi italiani di decente educazione.
Infine, ha
preso il tovagliolo e vi si è soffiato il naso con gran fragore, appena
soffocato dal rumore del treno. Poi, mi ha regalato, nonostante i miei
tentativi di cortese ripulsa, un grande e prezioso sigaro.
Era
un notevole industriale del New Jersey, e parlava un italiano
comprensibile. Ma quando la voce del treno ha detto m inglese che la
prossima
stazione sarebbe stata Bologna, mi ha chiesto aiuto: "Scusa,
io non
parli good italiane e non capisce ... che ha detto?".
In
realtà, lo "speaker" ferroviario non era dei
migliori, e di sicuro non aveva studiato ad Oxford.
Mi
raccontano quanto è accaduto ad una signora italiana che,
trovandosi in Svizzera e leggendo l'insegna di un negozio,
"Coiffeur", è entrata con decisione e, tra una miriade di donne sotto
il casco del parrucchiere, ha ordinato con decisione: "Un caffè senza
zucchero, please!"
Coiffeur
come caffè.
Mi
ritorna in mente un altro episodio. Mi trovava ad Amsterdam, e
cercavo affannosamente una strada. Naturalmente, non conosco una sola
parola di
fiammingo, e adoperavo il mio povero inglese. Ho fermato un passante e
gli ho
chiesto: "Do you speak english?". E lui mi ha risposto: "Yes,
I do". Il discorso è finito cosi: gli ho chiesto se parlava
inglese,
lui mi ha risposto di sì, e quindi si è allontanato in fretta, dopo
avermi
rassicurato sulla sua conoscenza delle lingue e senza aspettare la
richiesta
che avrei voluto formulare.
Ora
si apprende che, finalmente, l'Azienda filotranviaria di Roma
ha deciso di cambiare i cartelli che avvertivano, in italiano e in
inglese, di
non salire sugli autobus senza un biglietto acquistato nelle apposite
rivendite. Per quello italiano non c'erano problemi: "Acquistate il
biglietto prima di salire". Ma quello inglese suonava, press'a poco
così,
tradotto com'era da qualcuno che l'inglese lo aveva imparato, molto
frettolosamente,
in qualche scuola serale: "Senza biglietto, non si può andare avanti
nella
vita". Dopo qualche giorno, finalmente e in seguito a innumerevoli
proteste, si può leggere l'avviso esatto: "Do not board without a
ticket...". Lo ha fornito l'ambasciata britannica, in prima persona. La
vita, come si è finalmente appreso, è una cosa diversa.
La
realtà è che il nostro popolo, tra sue doti, non ha quella
della propensione per le lingue. Il suo dramma è che pretende di essere
poliglotta, ed è per questo motivo che tutte le lingue diventano una
versione
dell'angloromano, del siculotedesco, del francopiemontese e, in tutti i
linguaggi, ci ostiniamo a credere che, per andare "avanti nella
vita", bisogna pagare un pedaggio o un biglietto dell'Atac. Il che, a
pensarci
bene, non è del tutto sbagliato.
L.V.-
Uno dei drammi del nostro paese è formato dai continui
scioperi che paralizzano la nostra vita. Scioperi di benzinai, di
autotrasportatori, di controllori di volo, di autoferrotranviari e
perfino
scioperi di poliziotti che, con sollazzo dei malviventi, mettono in
ginocchio
quanto resta della nostra civiltà. Come affrontava questo tema Luciano?
Fran-
Mio padre odiava lo sciopero come istituzione. Non che lui
fosse contrario a chi manifesta per migliorare le sue condizioni di
lavoro Al
contrario. Riteneva solo sbagliato e ingiusto che, il più delle volte,
si
usasse questo, come mezzo per fare politica. Ma lo sciopero dei bancari
dette
modo a mio padre di appuntare un divertente pezzo di costume
Con
lo sciopero dei bancari è riaffiorata, d'improvviso, anche
l'ormai desueta felicità di girare per la città
senza una lira
in tasca.
E' una condizione umana bellissima. Si aggirano, per le strade,
mendicanti e
barboni che si avvicinano ai passanti e non chiedono l'elemosina;
dicono
soltanto: "Scusi, signore, ho finito il libretto degli assegni e la mia
banca è chiusa: potrebbe prestarmi tremila lire fino alla fine dello
sciopero?". E' difficilissimo, attualmente, che un comune mortale abbia
ancora tremila lire, in splendidi contanti, nel portafoglio: ma
trecento lire
forse sì, e si possono regalare. Nascono anche nuove forme di
solidarietà e dì
amicizia. Il mio giornalaio abituale, ad esempio, mi fornisce un enorme
numero
di pubblicazioni, senza pretendere per ora una lira. Così il tabaccaio
che mi
rifornisce di sigarette, sempre sulla fiducia. Un paio di giorni or
sono mi ha
prestato anche diecimila lire: me ne avrebbe date
molte di più,
ma aveva
il cassetto pieno dì assegni, che ha messo a mia disposizione, ma che
non avrei
saputo dove e come cambiare.
Se
questo sciopero continuasse, vorrei che qualcuno risolvesse un
mio dubbio ed ascoltasse una mia proposta. Il dubbio è ovvio: i
dipendenti
degli istituti di credito in sciopero hanno ricevuto e hanno
potuto
incassare i loro stipendi? La proposta è questa: torniamo al vecchio
baratto,
molto più nobile e meno rischioso del sistema monetario. In cambio
dì
otto uova, posso versare tre penne biro, un libro e due dispense sulla
storia
della seconda guerra mondiale. Per contro, per compensare i diritti
d'autore di
un libro o di una canzone, gli editori potranno
dare a uno
scrittore un
cosciotto d'abbacchio, una bottiglia di Chiantì e qualche chilogrammo
di
pomodori. Ritroveremo così la sana semplicità dei rapporti umani. E per
saldare
i nostri debiti con l'Ufficio imposte dirette verseremo una pecora,
sette paia
di calzini e una poesia autografa di Dario Bellezza, purché
quest'ultimo voglia
dare, come resto, una lettera inedita di Pasolini, con la quale potremo
acquistare tre scatolette di tonno e due confezioni di sale grosso.
Anche in
questo modo sì riscoprono le "radici" dell'umanità e si possono
ridimensionare i bancari, gli stipendi e perfino i premi letterari.
L.V.-
Insomma le cose che diceva e scriveva allora, sono ancora
attuali.
Fran-
Proprio così. E pensare che il Giubileo era ancora roba di
''un altro secolo''. E poi la nuova popolazione delle città, formata da
immigrati di tutti i tipi, di barboni, di mendicanti, di spacciatori,
di
prostitute e così via. Ma tutti costoro, per le sinistre, sono soltanto
emarginati da aiutare. A fare cosa, poi?
Non
amo le mezze parole, gli eufemismi cretini, le espressioni che
non riescono a consolare. E' inutile, a mio avviso, chiamare "non
vedente" un cieco. Un cieco è un cieco e basta. E lui lo sa benissimo.
Se,
con parole diverse e dolci, riuscissimo a regalargli il bene della
vista,
sarebbe giusta ogni parola meno cruda. Ma, per chi è cieco, ci vogliono
altro
che "definizioni obbligate", per restituirgli la possibilità di
vedere. Così, un muto è un muto: non serve chiamarlo, non so, "non
parlante". E non costituisce una terapia dire di un sordo che è un
"non audiente".
Questi
nostri amici, fratelli, parenti, sono ciechi, muti e sordi.
Bisogna ritrovare lì coraggio di chiamarli con i loro nomi esatti, sino
a
quando la medicina moderna, con le sue nuove scoperte, non sarà
riuscita a
guarirli dalle loro malattie. Altrimenti, a che cosa serve scherzare
con le
definizioni? Se vogliamo divertirci o sentirci più buoni e bravi con le
parole
e con gli eufemismi è un conto, ma se vogliamo davvero discutere con la
scienza
bisognerebbe entrare nel campo delle guarigioni, non del linguaggio!
Fran-
C’è un fatto che non dobbiamo dimenticare: qualsiasi notizia
diventava per lui l’occasione per esporre le sue idee. Non aveva molta
considerazione per la modernità, in senso lato, e in questo senso, come
dici
tu, era un conservatore. "Bisogna conservare tutto quello che
c’è di
buono nella nostra storia" diceva spesso.
L.V.-
Tuo padre ha usato molti pseudonimi, oltre al suo nome, come
mai?
Fran-
Aveva il timore di inflazionare. Sembra strano ma mio padre
era un uomo molto modesto, in questo. E così usò molti pseudonimi,
anche se
tutti sapevano chi si celava dietro nomi come Lucius Delno o altri.
Sotto lo
pseudonimo di ”Arcibaldo” mio
padre
curava una rubrica su un quotidiano, quasi al servizio del cittadino.
Le
lettere che i suoi lettori gli inviavano gli davano lo spunto per
affrontare
quei punti interrogativi, del tutto legittimi, che questo nostro paese
faceva
sorgere.
Li
vedo uscire da un'osteria di un quartiere popolare. Sono
vecchi, vestiti male, vacillanti. Lui è basso, tozzo, calvo. Lei
indossa il
vestito nero dell'antico lutto che pesa, da sempre, sull'anima di ogni
donna
del popolo che non abbia mai avuto pane sufficiente per i propri figli,
abiti
sufficienti per il proprio marito, nè amore sufficiente per le proprie
nottate
buie. Ora, uscendo dall'osteria, si sostengono a vicenda. Ormai i loro
figli,
se ne hanno avuti, sono sposati e certamente stanno cercando di
dimenticare
genitori così. Sono soli con tutta l'amarezza che si è raggrumata nei
loro
anni, con tutto il rancore che hanno accumulato l'uno contro l'altro,
con tutto
il vino che hanno bevuto insieme in questa serata di follia e con tutta
la
pietà che forse ognuno avverte per la delusa vecchiaia dell'altro.
Girano
all'angolo della strada e scompaiono in un vicolo oscuro. Sembra che
muoiano
così, nella notte del vicolo, senz’altro appoggio, senz'altra odiata
illusione
che quel braccio tremulo che si offrono l'un altro, per sostenersi a
vicenda.
L.V.-
Che rapporto aveva con la religiosità?
Fran-
Non lo dimostrava a tutti, ma mio padre aveva un profondo
senso della religiosità. Si trattava di una forma di religiosità che
non lo
legava a credenze particolari, anche se nel fondo del suo animo la
tradizione
cattolica era sempre presente.
Come ho già accennato,
l’elemento tradizionale era quello che maggiormente trapelava, non solo
da ogni
suo scritto ma da ogni sua azione. Per fare un esempio, e senza
confondere la
Tradizione con le tradizioni, le festività religiose che spesso sono
collegate
a modelli arcaici, erano un motivo di spunto attraverso le quali egli
si
divertiva a cogliere gli aspetti certamente meno religiosi ma più
''alla
moda" che a certi cattolici dichiarati piacciono tanto.
La
macchia di luce, del palazzo addormentato, creava sull'asfalto
uno sfumato chiarore. La gente, passando, camminava in punta di piedi,
per
evitare la pozzanghera lucente. Avevamo molte cose da dirci. Ma
quell'asfalto bagnato
di riflessi assorbiva i nostri pensieri e faceva nascere il desiderio
di non
parlare d'altro che di buio e di stelle al neon, di finestre illuminate
perdute
nei tempo ma ancora accese nel buio dei nostri. cuori addormentati, di
notti
vecchie come mura grinzose e fresche, nuove come pensieri di felicità,
quando
luce buona, luce di sole, filtra dolce dalle finestre spalancate e
carezza le
coperte di un letto per sognare. Disse sarebbe tutto bello, Sarebbe,
disse. E
non era non era mai stato, non sarebbe mai accaduto che fosse realmente
bello,
bello per queste strade che sono e non sarebbero, bello per queste mani
che
fanno e non farebbero, bello per questo mondo che è. Dissi forse
sarebbe bello.
Perché siamo presenti, noi, e niente è bello per sempre, finché ci
saremo noi,
i nostri volti ebeti, i nostri pori dilatati, le nostre mani tremule.
La nostra
angoscia nata da una eterna vecchiaia, da una nostalgia di prima, di
prima, di
prima ancora che ci fossero L'evento il mondo gli uomini e questo
desiderio di
bello
L.V.-
Il 1997 fu l'anno di Dario Fo; qualcuno lo ha scoperto,
qualcun altro riscoperto. Noi, in cabaret, ne discutevamo parecchio ma
lo
consideravamo un ottimo attore. Non dimentichiamo che per uno dei suoi
spettacoli Luciano assunse Giustino Durano.
Fran-
È vero. Sembrava avere il gusto del paradosso. Dario Fo era
un personaggio anche allora, ma oggi è riuscito a sconvolgere anche il
premio
Nobel.
Ma sul personaggio Fo, così originale nel panorama teatrale,
mio padre aveva scritto alcune considerazioni già nel 1962, in una
lettera
aperta indirizzata a sua moglie Franca Rame. (che oggi, purtroppo, non
c’è più)
Gentile
signora Rame, innanzitutto debbo spiegarle perché mi
rivolgo a lei, anziché a suo marito. Il fatto è che gli "intellettuali
di
sinistra" (o aspiranti tali) come suo marito, mi sono venuti
profondamente
a noia. Ho in uggia la loro saccenteria, il loro tono messianico, i
loro
sorrisi e le loro tristezze, il loro coraggio fasullo e la loro
autentica resa
ai miti balordi del nostro tempo. Per questo, evito accuratamente,
oramai, di
parlare con loro: conosco i loro ragionamenti, le loro pose e la loro
retorica;
so a memoria le astuzie dei loro sovversivismo comodissimo, che si
esprime
sempre con l’approvazione e il plauso dei potenti. Ma tutto questo non
implica,
ovviamente, che io e molti telespettatori con me, abbia in uggia anche
le mogli
degli intellettuali, di ruolo o avventizi, della sinistra nostrana:
anzi, molte
cose si perdonano a questi menestrelli del sole dell'avvenire, in
considerazione
della silhouette, a volte decisamente gradevole,
delle loro
consorti.
Ecco perché preferisco rivolgermi a lei, anziché al suo Dario. E sono
spiacente, gentile signora, di doverle dare subito torto. Nel corso di
una
recente intervista, parlando di Dario Fo, della sua intelligenza
svagata e
della sua varia umanità, ella ha detto: "Dario
è un lunare,
si trova qui per caso. Viene decisamente da un altro
mondo..". E questa,
sinceramente, mi sembra una clamorosa bugia. Non so che cosa le abbia
raccontato
suo marito a proposito delle proprie origini; ma posso assicurarle che
se le ha
fatto credere dl provenire dalla luna, ha sfacciatamente mentito. Egli
è un
terrestre, e riassume in se tutta la stanchezza e la voglia di vivere
tranquillamente, tutta l'astuzia e tutta la filosofia del "tengo
famiglia" che caratterizza gli uomini del nostro pianeta decrepito. Non
si
lasci incantare dal suoi atteggiamenti di "pasionario", dalle sue
dichiarazioni di ribelle con licenza dei superiori, dal suoi toni di
socialitario
per vocazione e per destino: egli è soltanto un cittadino di questa
terra che
ha capito tutto e ha per tempo alzato il ditino bagnato per conoscere
la
direzione del vento, adattando prontamente ad essa il proprio
orientamento.

Dubito,
cara Signora, che le sia accaduto spesso di
essere guardata negli occhi da un uomo. Ma è ora di farlo: guardiamoci
dunque
negli occhi, e cerchiamo di essere sinceri. Crede davvero che, in una
situazione come quella attuale, ci voglia un gran coraggio per parlare
di Buchenwald
o per canzonare i capitalisti? Ma un’altra cosa vorrei dirle. Qualche
tempo fa
il compagno Togliatti disse che tutti, in Italia, dalla politica
all'economia e
potremmo aggiungere , allo spettacolo, si svolge in funzione di "cento
famiglie da salvare". C'è qualcosa di vero, in questa affermazione del
Migliore. Ed è indubbio che tra queste Cento famiglie per cui il
favoloso
"miracolo italiano" è effettivamente e gioiosamente esploso, figura
la famiglia Fo. Mi perdoni, cortese signora, ma c'è aria di trucco, in
un
siffatto atteggiamento. Infatti la sua satira contro la gente dalla
ricchezza
facile sembrerebbe molto più vigorosa, se egli rifiutasse gli onerosi
compensi
che si fa dare, chiedendo prima un giusto trattamento per i casellanti
ferroviari e per i braccianti agricoli. Cerchi Lei di convincere suo
marito,
Lei ha argomenti per convincerlo, se vuole. E soprattutto non si lasci
fuorviare dalle sue istanze cerebrali, Da qualche tempo, infatti, il
pubblico
assiste, con vivo allarme, alle dichiarazioni che Lei rilascia alla
stampa nel
tentativo di convincere gli altri e se stessa che Lei è una grande
attrice.
Dicono che lei "è stanca delle critiche che si concludono con
l'ineluttabile : bella la Rame”. Ebbene, signora, lasci
perdere.
C'è chi
nasce bella, con tutte le curve prescritte dalla consuetudine, e c'è
chi nasce
brava, con tutti i requisiti che si pretendono in una grande attrice; e
a volta
succede che qualcuna nasca con le due qualità, e sia bella e brava: ma
succede
molto di rado, e soltanto quando il buon Dio si trova in un periodo di
particolare euforia e vuole dimostrare agli increduli di che cosa sono
capaci,
lassù, Lei è nata bella e tanta, gentile signora: ringrazi la
Provvidenza che
non è stata parsimoniosa, nei suoi confronti, ma non si abbandoni alle
illusioni, il nume che veglia sulle sorti del teatro si inquieta molto
quando
viene a sapere che una viva si sente matura per Shakespeare o per
Pirandello
per il solo fatto di possedere un paio di gambe pregevolissime. Del
resto, in
questo clima di cerebralismi cretini e di grandi truffe, abbiamo molto
più
bisogno dl donne che sappiano portare con disinvoltura tutte le loro
curve che
non di attrici sbagliate e illuse. Tanto le doveva, cara signora, uno
spettatore deluso e nauseato, che non ha più alcuna fiducia negli
intellettuali
di sinistra ma vuole ancora illudersi sul conto delle loro rigogliose
consorti.
L.V.-
Parlando di Dario Fo, non si si può sfuggire al tema della
letteratura e dei premi. Mi sembra che egli non amasse molto certo
genere di
manifestazioni.
Fran-
Mio padre, soprattutto, odiava l’ipocrisia. Era il periodo
in cui in Italia qualcuno sentiva, forte, il bisogno di premiare e di
premiarsi. I premi, letterari o meno, cominciarono a moltiplicarsi,
tanto che
cominciò a essere difficile incontrare nei salotti buoni qualcuno che
non fosse
stato premiato, magari per il Premio letterario "Sagra del
Carciofo".
Per
ragioni di lavoro sono stato costretto a partecipare alla
cerimonia di assegnazione di un importante premio letterario romano. Lo
avrei
evitato volentieri, perché ormai so come vanno queste cose. Si respira
un'atmosfera rarefatta, vagamente irreale, tra giornalisti che fingono
di
ascoltare quello che alcuni scrittori fingono di confidare in onestà,
mentre
signore, illustri o analfabete, esaminano con cupidigia o disprezzo i
rispettivi abiti e c'è sempre l'ignaro cronista di una radio privata
che,
appoggiando il microfono sui denti di Massimo Grillandi gli chiede:
"Domandiamo a Carlo Cassola che cosa pensa delle opere di Massimo
Grillandi...". E Massimo Grillandi, che ha anche il senso
dell'umorismo,
risponde quietamente: "Tutto il bene possibile. Per me, è il più grande
scrittore del mondo...". Ma sono rare queste occasioni di allegria. Mi
trovo accanto a Luciano De Crescenzo, l'ingegnere umorista che ha
scritto
recentemente, e inopinatamente, una "Storia della filosofia greca".
"Ho saputo - gli dico - che il tuo libro ha venduto, in una settimana,
più
di centomila copie. Una cifra da capogiro, in un paese come il nostro,
in cui
la gente legge soltanto le scritte spray sui monumenti...".
Col
suo sorriso napoletano e i suoi occhi da consapevole scugnizzo
allegro e invecchiato in fretta, mi confida: "È vero. Sono state
vendute
tante copie del mio libro che nemmeno il distributore ci credeva...".
Cerco di provocarlo: "Allora, certamente vincerai un premio...".
"Non se ne parla proprio! In Italia, se ti diverti a lavorare, se ti
diverti a scrivere, se ti diverti a vivere, non ti premiano mai. Ma
come?,
dicono, quello fa la televisione, il cinema, abbraccia Lori Del Santo,
se la
spassa con Arbore, Benigni, la filosofia greca, e bisogna pure
premiarlo?
Quando sarà morto e saremo sicuri che non riderà più, ne
riparleremo...".
Una
bellissima signora gli passa accanto, lo riconosce, lo
abbraccia e lo bacia, allontanandosi promettendo un vago appuntamento:
"Ecco - dice De Crescenzo - con questo bacio ho perduto almeno altri
dieci
anni di premi letterari. E se poi arriva quel matto di Arbore e ci
mettiamo a
ridere tutti insieme, non se ne parla più per l'eternità".
Infatti,
in un capannello poco distante, distinguo alcuni
letterati alla moda, tra i più reclamizzati dei nostri giorni e che
nessuno
legge. Sembrano affiliati alla compagnia della buona morte: hanno
sguardi
opachi, volti lugubri, espressioni affrante. Forse sono intenti a
parlare di
letteratura contemporanea o di qualche altro caro estinto, ma certo
suggeriscono l'idea di prefiche munite di silenziatore, intente a
esorcizzare i
lutti del inondo in un fiume di malinconia. Giunge dal gruppo, in
un'improvvisa
pausa di silenzio, la voce un tantino roca dello scrittore che, pochi
minuti
dopo, vincerà il premio. Egli dice con tono affranto: "Il nostro
indimenticabile Vincenzino me lo diceva sempre: a che serve più
scrivere? Smettila,
tu che sei giovane e fai ancora in tempo".
Lo
sciagurato non ascoltò Vincenzino e non smise. E ora riceve,
con aspetto sempre più da "zombie", il premio che gli è stato
attribuito. Gli sta bene. Così, un giorno o l'altro, dopo aver vinto
l'ultimo
premio disponibile, potrà, piangendo, scegliere l'onorata strada del
suicidio.
A ridere resteranno i filosofi, latini o greci.
Fran-
Non era certo questa l’Italia per la quale aveva scritto,
lottato caparbiamente per ritirarsi, sconfitto, lasciando libero il
campo ad
improvvisati scrittori, a contemporanei scontati (anche perché
l'intelligenza è
a buon mercato), loschi tipi assoggettati a quello o quello altro polo.
Mi
manca molto una sua risposta, anche per aiutarci a ritenerci fortunati
di
essere ancora qui, ma potrei parafrasarlo: “Certi onori non basta
rifiutarli,
bisogna imparare a non meritarli”.
Questo era mio padre Luciano Cirri, un Uomo. Un poeta che
guardava
lontano, che scrutava con i suoi occhi color cielo, orizzonti infiniti
nella
ricerca di qualcosa di vero, di sacro per il quale potesse valere
ancora la
pena di esistere.
